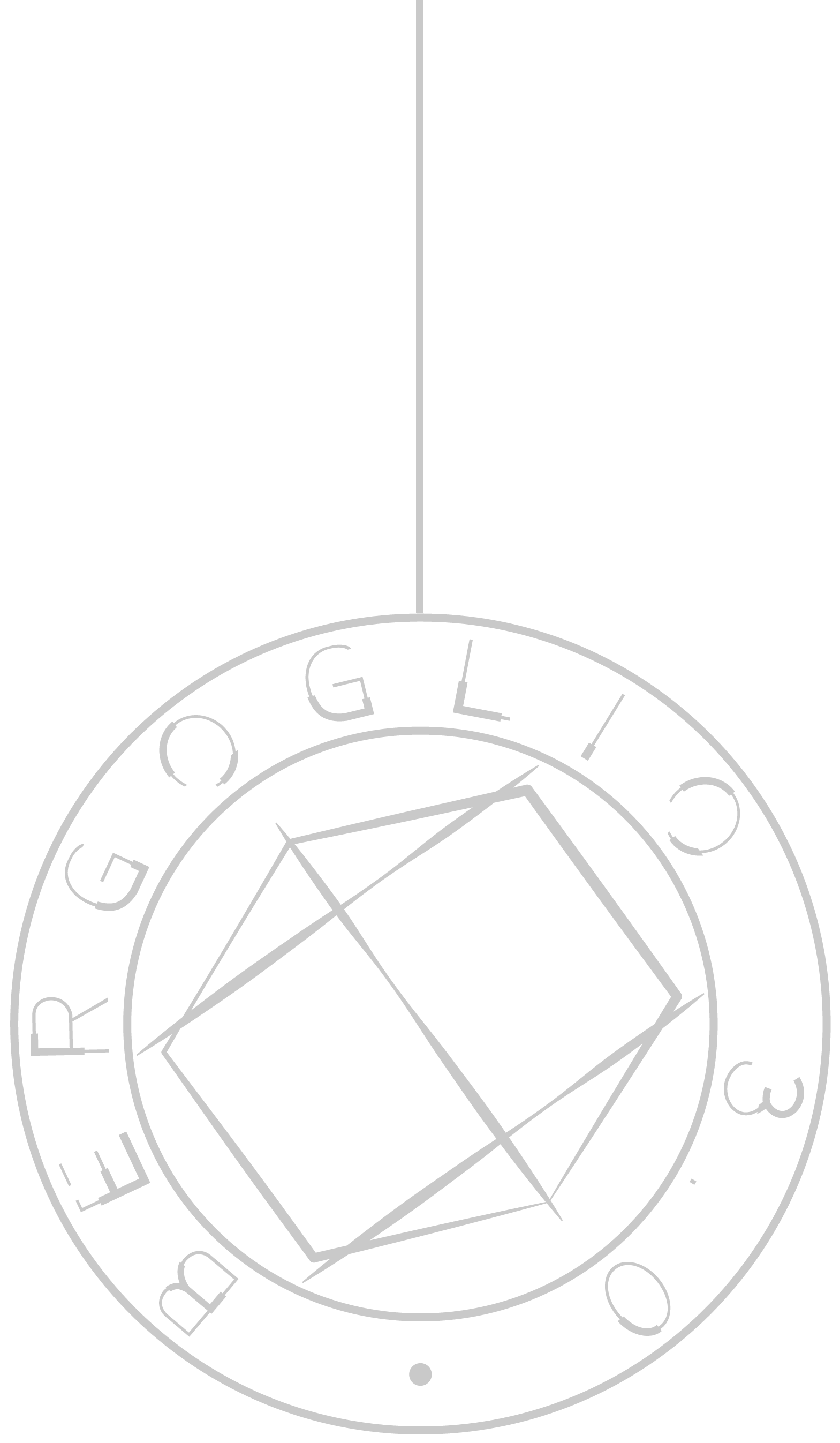Plebs civitatis & ecclesia major
a fondazione di Alessandria ha avuto premesse e situazioni storiche molto complesse, sia per quanto riguarda i punti di appoggio in centri demici organizzati, sia per quanto concerne l’atmosfera dell’ambiente. Nell’isolamento topografico e strutturale delle curtes e dei borghi, nella loro appartenenza a diocesi diverse, ed anche a diverse signorie feudali, il monastero creò gradualmente rapporti di colleganza, interessi comuni e nodi di convergenza. Fu appunto questa la situazione dell’area in cui sorse Alessandria: formata da tre sistemi territoriali: le due curtes di Bergoglio e di Rovereto, e un’area deserta o semideserta: quella di Palea, appartenente, dal punto di vista distrettuale, alla curtis di Rovereto. Volendo assurgere alla dignità di città anche dal punto di vista ecclesiastico, in modo, oltre tutto, da potere affermare la propria esistenza giuridica non solo di fronte all’Impero ma anche alle città circonvicine, Alessandria abbisognava innanzi tutto di una plebs civitatis, con il proprio centro in una cattedrale.
La costruzione della cattedrale
L’operazione fu condotta in due tempi. Nel 1170 i consoli cittadini di Alessandria acquistarono un sedime per costruirvi un’ecclesia (si noti l’adozione di un termine che consente la qualificazione successiva di major, cioè di chiesa cattedrale). In un’ambasceria a Roma, i consoli Ruffino Bianco e Guglielmo de Bergomonte offrirono alla Sede Apostolica, con la tipica cerimonia dell’offerta feudale, ma in perpetuo, la terra per la costituenda chiesa che, non potendo coincidere, per evidenti ragioni di rappresentanza dell’intera comunità, con la chiesa già esistente della curtis di Rovereto, e tanto meno con quella di Gamondio o Marengo o Borgoglio, dovette perciò venire ubicata in Palea. Su di essa i consoli promisero un censo annuo di tre denari da parte della comunità, da versarsi nella festa di San Martino, ed un censo annuo, ugualmente di tre denari, sempre nella festa di San Martino, per ogni gruppo familiare dei futuri fedeli; infine giurarono fedeltà al papa e gli resero omaggio. Era in sostanza un implicito riconoscimento del diritto della futura cattedrale alla riscossione delle decime. Una corrente di pensiero giuridico, richiamandosi alla donazione di Costantino, asseriva che il pontefice poteva emanare leggi e decreti al di sopra dell’autorità dell’imperatore. Per questa via, praticata nel 1170, la nuova città cercò di legittimare il difetto della propria nascita, diventando, come ha scritto Francesco Cognasso, una signoria feudale del pontefice, poiché non v’è da dubitare, seppure manchi una precisa documentazione in proposito, che egli accolse l’offerta dei consoli alessandrini, in quanto gl’interessi della Chiesa coincidevano con quelli della Lega ed altresì con le esigenze dello sviluppo civile e religioso della società locale. Né poteva spiacere al pontefice l’idea di avere in questo delicato settore dell’Italia nord-occidentale un organismo nuovo, della cui fedeltà egli poteva essere sicuro in ogni momento.
L’evento successivo è quasi obbligatoriamente consequenziale, già previsto ed in certo modo preordinato da quello del 1170, ma che si verifica forse più ancora per il fallimento degli attacchi federiciani alla nova civitas che per lo sviluppo urbanistico, politico, economico-sociale di quest’ultima. Nel 1175 la nuova chiesa venne elevata alla dignità di cattedrale, ancora da papa Alessandro III, che le assegnò la diocesi alessandrina, composta dagli otto luoghi da cui era nata e si era accresciuta Alessandria – Bergoglio, Gamondio, Marengo, Rovereto, Foro, Quargnento, Solero, Oviglio – più la pieve di Masio, in valle Tanaro, smembrata dalla diocesi di Acqui, la pieve di Retorto, in valle d’Orba, smembrata o dalla diocesi di Tortona o, più probabilmente, da quella di Acqui. Non è chiaro tuttavia quale sia stata l’area di pertinenza della cattedrale per l’esercizio dci suoi diritti parrocchiali entro la città, di fronte ai diritti delle chiese pievane (ad esempio, di Rovereto e di Bergoglio) che preesistevano alla fondazione della civitas nova, od a quelli che gli immigrati (ad esempio, da Marengo e da Gamondio o da Quargnento) portavano con sé.
Comunque con la creazione della nuova diocesi furono gradualmente sanate le originarie situazioni diverse degl’immigrati per le diverse origini e dipendenze pievane e parrocchiali (si pensi anche soltanto alla sopra citata questione del pagamento delle decime), dandosi rapidamente luogo alla fondazione della comune coscienza civica, già stimolata dalla ricerca di una univoca identità di fronte all’aggressione del Barbarossa e nella faticosa elaborazione di un medesimo status giuridico comunitario. Ed è indubbio che la strutturazione diocesana contribuì efficacemente alla nascita del senso civico comunitario alessandrino, cementato da un medesimo culto dei santi patroni e dalla nascita dell’idea-forza della missione spettante alla nuova città sul fronte guelfo.
La costituzione della diocesi alessandrina
Si trattò all’origine d’una diocesi piccola (e ciò andò a vantaggio della rapidità del suo processo di coesione), bene diversa, sotto questo aspetto ed anche strutturalmente, da quelle circonvicine, soprattutto da quella di Tortona. A nord il Tanaro segnava il confine, a ridosso della città, oltrepassando il fiume soltanto in corrispondenza di Bergoglio, mentre già Astigliano rientrava nell’ambito della diocesi pavese. Ad ovest fecero parte della nuova diocesi Lu, Cuccaro, Fubine, Quargnento, Solero, Felizzano, Villa del Foro ed Oviglio, Bergamasco e Carentino. Poi il confine volgeva a sud, includendo Gamondio, la zona della campagna a nord di Casalcermelli (dove la chiesa di San Vigilio d’Orba era stata donata nell’891 dall’imperatore Guido al vescovo di Acqui), la zona di San Leonardo a nord di Castelspina, Portanuova. Ad est comprendeva l’area di Marengo, escludeva Bosco, si allargava sino a comprendere San Giuliano, risaliva il Tanaro includendo Castelceriolo.
Fu comunque una diocesi abnorme, dal punto di vista strutturale: fondata non sull’ordinato tessuto di una serie di pievi, tra loro vincolate da una comune tradizione storica, ma sopra un quadro composito di chiese staccate dalla propria matrice, di cappelle promosse rapidamente al rango di parrocchie, di nuove fondazioni, trasferite in titolo dalle antiche sedi ai nuovi quartieri cittadini. E tuttavia il nuovo episcopato raggiunse una propria decisa personalità, come dimostra la vicenda immediatamente successiva. Se infatti nella nascita di Alessandria potevano trovarsi d’accordo a priori, tra i vescovi interessati territorialmente, quello di Milano ed eventualmente quello di Asti e quello di Tortona, difficilmente potevano esserlo gli ordinari di Pavia e di Acqui, entrambi per motivi connessi con lo scisma che contrapponeva papa Vittore V, sostenuto dall’imperatore Federico ed al quale andavano le loro simpatie, a papa Alessandro III, favorevole ai Comuni ed alla Lega Lombarda, tant’è vero che la civitas nova prese da lui il nome.
Anche se sacrifici notevoli vennero sopportati sul piano territoriale dalla diocesi di Tortona e poi da quella di Asti, una lunga tradizione storiografica considera la diocesi acquese come quella maggiormente colpita dagli smembramenti a favore di Alessandria. Essa si appoggia addirittura ad una «bolla» di papa Innocenzo III, il quale nel 1305 diede credito ad una derivazione della diocesi alessandrina in massima parte da quella acquese. «Molte chiese della diocesi di Acqui scrive il papa sono state assegnate a quella di Alessandria». In realtà la tradizione della diocesi alessandrina quasi come filiazione di quella acquese, e tutte le vicende che a tale tradizione si collegano, nacquero già ab origine dalla diversa posizione politica dei due episcopati tra papa ed antipapa e poi soprattutto dalla politica espansionistica di Alessandria, proiettata costantemente verso il sud, sia per i suoi collegamenti con Genova, da cui la nuova città aveva trovato forte appoggio per la propria fondazione e con cui erano insorti intensi i rapporti economici, sia perché solo in questa direzione appariva possibile una vigorosa affermazione diplomatico-territoriale nell’ancora fluido tessuto piemontese-monferrino di scadenti aggregati feudali e di deboli affermazioni comunali.
Alessandria antagonista di Acqui
Per il vescovo di Acqui le mutilazioni inflitte alla sua diocesi per la creazione della diocesi alessandrina, sebbene non esiziali né essenziali, facevano tuttavia presagire una minaccia per resistenza della cattedra vescovile. Acqui era una sede episcopale ed un capoluogo amministrativo di vetusta tradizione e rilevante importanza. Basterà ricordare che essa secondo il capitolare olonese del maggio 825, emanato da Lotario I, faceva corpo con Genova, Asti, Tortona, Vercelli, Novara, Milano, Como, Bergamo, Lodi, Brescia nel distretto i cui studenti dovevano recarsi a continuare i loro studi in Pavia. Ed ora invece la civitas nova iniziava a trasferire a sé da Acqui la sede episcopale della diocesi o per lo meno a smembrarne una buona parte, e ciò con tanto maggiore insistenza ed autorità quanto più il nuovo Comune veniva acquistando prestigio politico, rilievo economico, capacità militare, organizzazione amministrativa ed autorità territoriale, consolidandosi nelle sue autonome strutture di governo ed ampliando il quadro della propria legalità, dopo l’implicito riconoscimento da parte della Sede Apostolica. Tutto ciò indipendentemente dalla posizione filo-imperiale dell’episcopato acquese e quindi dalla sua propensione per la linea degli antipapi federiciani.
Che se poi la marca aleramica del 950-951, creata, insieme con la obertenga e la arduinica, da Berengario II e Adelberto, non aveva rappresentato, come scrive uno storico eminente, «un rigido insieme di comitati, sistematicamente strutturato, in ciascuno dei quali il marchese assume anche la funzione comitale», ma era stata, se non semplicemente un «onorifico titolo», per lo meno «un dispositivo di difesa, costituito da più territori, occupati in profondità» ed affidati ai singoli comites sotto l’organizzazione gerarchica del marchio, per cui, a proposito delle «nuove marche» l’accento andrà piuttosto spostato dal territorio alla persona del «marchese», appare evidente il rilievo assunto da Acqui nelle strutture del secolo X, tutto ciò sembra comprovato dal fatto stesso che proprio ad Acqui si svolse nel 935-936 l’unica battaglia vittoriosa contro i Saraceni che il cronista Liutprado ricordi. E la funzione di presidio politico, economico, militare, l’episcopato e comitato di Acqui continuarono a svolgere ancora tra il secolo X e l’XI, come è dimostrato dalla fondazione del monastero di San Quintino di Spigno nel 991 e di quello di Santa Giustina di Sezzadio nel 1030. Anche il titolo di conte del Sacrum Imperum, espresso sistematicamente dal vescovo d’Acqui a partire dal 1343, ha effettivamente valore soprattutto formale, il richiamo implicito dell’Impero venne a sancire, seppure tardivamente una sorta di superiorità procedurale dell’ordinario acquese, mentre ancora ferveva il contrasto con la sede alessandrina per la diocesi.
In effetti il conflitto, determinato tra Acqui ed Alessandria in sede di struttura ecclesiastica dalla vicenda del 1175, riflette in un certo modo lo scontro politico tra la parte imperiale e le posizioni antifedericiane in Italia. Ma soprattutto la creazione della diocesi di Alessandria, con territori tolti anche alla diocesi di Acqui, faceva di quest’ultima città, epicentro comitale nell’Alto Monferrato e sede di diocesi, la naturale antagonista di Alessandria anche sotto il profilo ecclesiastico. Non sembra un puro caso il fatto che la civitas nova proprio nel momento culminante del conflitto tra la Lega e l’Impero, quando la stessa Alessandria è stata assediata da Federico, tra ottobre 1174 ed aprile 1175, ottenne una sua diocesi: era un duro colpo, in una circostanza scelta molto opportunamente, per Acqui, il Monferrato e gl’imperiali. La diocesi veniva oltre tutto a sancire e perfezionare le interne strutture del governo cittadino che la nuova città si era date, onde raggiungere al più presto una propria qualificazione e configurazione giuridico-amministrativa. Basti ricordare che già nel 1172 gli alessandrini, membri di una città, che è priva di personalità giuridica nel quadro dell’ordinamento dell’Impero, volendo indicare il luogo della loro ubicazione urbana con valore legale, ritennero di risolvere il problema e di affermare una posizione di prestigio nei riguardi sia dell’Impero sia del Monferrato, dicendo, nel trattato con Gavi, che la loro città «est posita in loco Roboreti».
E una dizione grazie alla quale gli Alessandrini, con un richiamo alla curtis regia, non solo localizzano topograficamente il sito, ma anche cercano di conferirgli una veste di legalità. Al che Federico risponde nel 1174-75 usando appunto la datazione: «in obsidione Roboreti»: una dizione, suggerita in fondo dagli stessi Alessandrini, per virtù della quale egli non riconosce l’esistenza della nuova città, ma legittima la propria guerra contro una sua terra – Rovereto – ribelle. In realtà la situazione oggettiva si fa strada anche fra i contemporanei, contestualmente, nella dizione usata dall’Anonimo Laudunense che parla di «Alexandria, civitas de Palea»: forse meglio ancora in Goffredo da Viterbo quando scrive: «Burmia cum Tanaro Palearum fecerat urbem».
Rafforzamento della legittimità sulla fondazione e poteri feudali
Ottenuto lo status giuridico di sede diocesana, che già rappresentava una prima formalizzazione verso la piena legalità, Alessandria si adoperò, per affermarla, rafforzarla ed evidenziarla al massimo nel quadro istituzionale, nei poteri, nella dignità, nella funzione. Nel momento maggiore della crisi politica generale, precisamente nel gennaio del 1176, essa ottenne che papa Alessandro III concedesse al clero cittadino la facoltà della libera elezione del vescovo, «sicut canonici ecclesiarum cathedralium, que Mediolanensi Ecclesie subiacent, habere noscuntur». Il richiamo alla sede metropolita milanese, a cui Alessandria viene conseguentemente sottoposta, rappresentò una sanzione definitiva al fatto compiuto della nuova diocesi, un perfezionamento dell’immagine, una garanzia di tutela. Grazie anche al suo nuovo rango di sede diocesana, la città puntò allora decisamente a legalizzare i suoi rapporti con l’Impero approfittando del cambiamento della situazione generale, determinato dalla sconfitta federiciana a Legnano nel 1176. La nova civitas seguì di nuovo un percorso diplomatico molto abile, volgendosi, prima, a risolvere il conflitto con la feudalità locale, di cui aveva usurpato diritti e possessi e che poteva altrimenti, anche se sconfitta, continuare a costituire un ostacolo giuridico contro l’accordo con l’Impero.
La dipendenza feudale alessandrina implicava sia il territorio sul quale la città sorgeva, sia gli abitanti giunti a popolarla dai feudi circonvicini, sia le terre che gl’immigrati possedevano in area feudale. I marchesi del Bosco vantavano diritti di proprietà, in tutto o in parte, sullo spazio occupato dalla nova civitas; quelli di Monferrato, oltre alla superiore autorità di governo, reclamavano giurisdizioni personali. Con Guglielmo il Vecchio, che, nella sua veste di marchese di Monferrato, rappresentava, anche dopo la sconfitta di Legnano, la maggiore autorità nel governo feudale del territorio, fu raggiunto il primo accordo, tanto più significativo ed importante perché il marchesato monferrino era stato il più gravemente colpito dal fatto stesso della nuova fondazione.
Il trattato di pace del 1178 col Monferrato rappresentò per Alessandria un implicito riconoscimento della validità giuridica della sua fondazione, che aveva scisso in due il Monferrato medesimo, e pose in sottordine le eventuali rivendicazioni dei marchesi del Bosco. Alessandria pagò un prezzo relativamente modesto e transitorio, dal momento che essa era dalla parte vincitrice: l’impegno al giuramento di fedeltà da parte dei cittadini al marchese, ed in particolare il vassallatico degli abitanti della nova civitas che provenissero, essi medesimi o i loro maggiori, da Marengo, Gamondio e Foro. A sua volta il marchese s’impegnò a venire ad abitare nella città e promise d’interporre i suoi buoni uffici presso l’imperatore al fine di ottenere il riconoscimento della condizione civica degli Alessandrini. L’impegno del marchese all’abitacolo in città rappresentava non solo una garanzia politico-militare, ma altresì un’affermazione dell’autorità comunale sul potere feudale.
Poi, nel 1180 Alessandria giunse alla definizione dei suoi rapporti con i marchesi del Bosco: famiglia feudale in rapido declino, premuta tra le forze comunali dalla Riviera Ligure alla val Padana e insidiata dagli stessi Monferrato. Non vi sono qui vincoli di vassallaggio, neppure per determinati gruppi civici, mentre il riconoscimento, da parte del marchese, riguardò non solo lo status civitatis, ma altresì lo status terræ, vale a dire lo stesso spazio sul suolo, arbitrariamente occupato dalla fondazione della città: il che ci conforta nell’opinione che ai Del Bosco appartenesse, almeno in parte, l’area della Palea; dove convennero i primi immigrati.
Un altro passo importante sul piano territoriale gli Alessandrini effettuarono con la convenzione del 1180 con i marchesi del Bosco. Restituirono ai legittimi proprietari – i marchesi – quella parte dell’area tra la Bormida ed il Tanaro che non era stata totalmente occupata dalla costruzione della nuova città. Ottennero però la cessione in feudo sia del castrum e della villa di Ponzano, immediatamente oltre il Tanaro, a nord della città, corrispondente all’odierno centro di Montecastello, sia di Maranzana, al sud, oltre la Bormida, lungo la via che porta a Gamondio (Castellazzo Bormida). Si pongono così i temi che verranno sviluppati dalla storia successiva: a nord verso Casale, Vercelli, Novara e la Lombardia; a sud verso la valle Scrivia, sulla strada di Genova.